La storia della crittografia
Una delle prime tracce storiche di uso di queste tecniche risale a Giulio Cesare che si narra utilizzasse un cifrario consistente nelsostituire ad ogni lettera la terza lettera che la segue nell'alfabeto.
Ben presto per metodi così arcaici vennero scoperti metodi di soluzione generale, segnando anche la nascita della crittoanalisi.
Nel corso della storia le due arti contrapposte (crittografia e crittoanalisi) hanno affinato sempre più le loro armi, dando spesso l'impressione che una delle due fosse destinata a prevalere sull'altra. Oggigiorno, la guerra si è spostata nella teoria dei numeri, la branca più astratta della matematica, dimostrando che perfino la scienza più astratta può avere decisivi effetti sulla vita di tutti i giorni.
Gli ultimi prodotti della crittografia sembrano a tutti gli effetti inattaccabili, ma la storia insegna che è forse troppo presto per giudicare, benché gli odierni risultati siano basati su metodi sempre più precisi e controllati e non sull'intuito personale del crittologo.
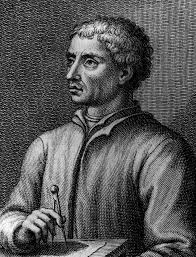

La storia della crittografia inizia con la stesura del De Cifris di Leon Battista Alberti, che per primo iniziò a cifrare per mezzo di un disco cifrante.
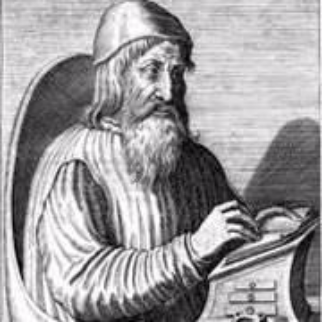
Anche il tedesco Tritemio previde una forma di cifra polialfabetica, facendo scorrere l'alfabeto ordinato di un posto ad ogni lettera del chiaro (come si definisce in gergo l’alfabeto non modificato).
Nel 1526, invece, Jacopo Silvestri pubblicò l'Opus novum, considerata una delle prime opere su questo argomento (traslazione). Ma il vero progresso nella cifratura polialfabetica è stato compiuto dal bresciano Giovan Battista Bellaso, che ha inventato la tecnica di alternare alcuni alfabeti segreti formati con parola chiave sotto il controllo di un lungo versetto chiamato contrassegno. La sua prima tavola a 11 alfabeti reciproci, uscita nel 1553, fu ripubblicata dal napoletano Giovanni Battista Della Porta dieci anni più tardi e ne prese il nome grazie alla notevole diffusione che ebbe il suo trattato De furtivis literarum notis. Il francese Vigenèra utilizzò poi il versetto per cifrare ciascuna lettera con la sua tavola ad alfabeti regolari identica a quella del Tritemio e che oggi porta il suo nome. Il suo sistema è stato considerato indecifrabile per tre secoli, finché nel 1863 il colonnello prussiano Friedrich Kasiski non pubblicò un metodo per "forzarlo", chiamato Esame Kasiski
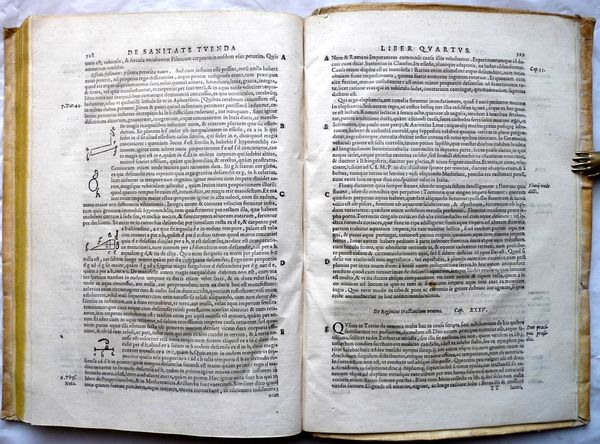
Qualsiasi sia il sistema crittografico utilizzato, la legge fondamentale sul corretto uso di tali tecniche fu scritta da Kerckhoffs ("Legge Kerckhoffs") nel suo libro del 1883 La Cryptographie Militaire e di seguito riportata: «La sicurezza di un crittosistema non deve dipendere dal tener celato il crittoalgoritmo. La sicurezza dipenderà solo dal tener celata la chiave.»
Nel 1918 Gilbert Vernam maggiore dell'esercito statunitense e tecnico all'AT&T Bell, perfezionò il metodo di Vigenère proponendo l'idea di usare chiavi segrete casuali lunghe almeno quanto il messaggio. Successivamente, nel 1949, Claude Shannon, padre della teoria dell'informazione, nel lavoro la teoria della comunicazione nei sistemi crittografici dimostrò che questo è l'unico metodo crittografico possibile che sia totalmente sicuro.
Con il possesso di un sistema crittografico perfetto, la battaglia teorica tra crittografia e crittoanalisi si è risolta con una vittoria della prima sulla seconda. Ipotizzando di voler far uso di questa insuperabile protezione, restano però aperti molti problemi di ordine pratico. Bisogna infatti soddisfare gli stringenti requisiti del cifrario di Vernam: chiave lunga quanto il messaggio e mai più riutilizzabile. Tuttavia si hanno notizie di utilizzi di questo cifrario in ambiente militare (comunicazione con le spie: si veda a proposito One Time Pad), o per la protezione delle comunicazioni del telefono rosso tra Washington e Mosca durante la guerra fredda. Anche il cifrario trovato nel 1967 sul corpo di che Guevara è un'applicazione del cifrario di Vernam.